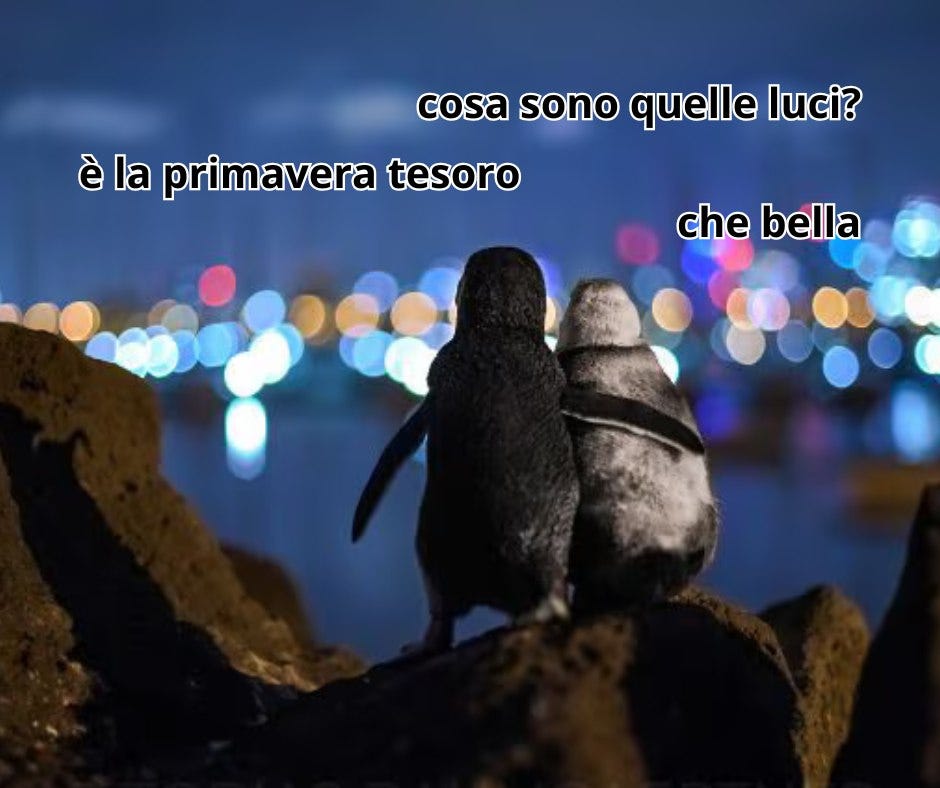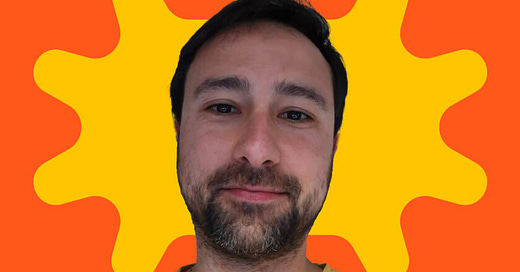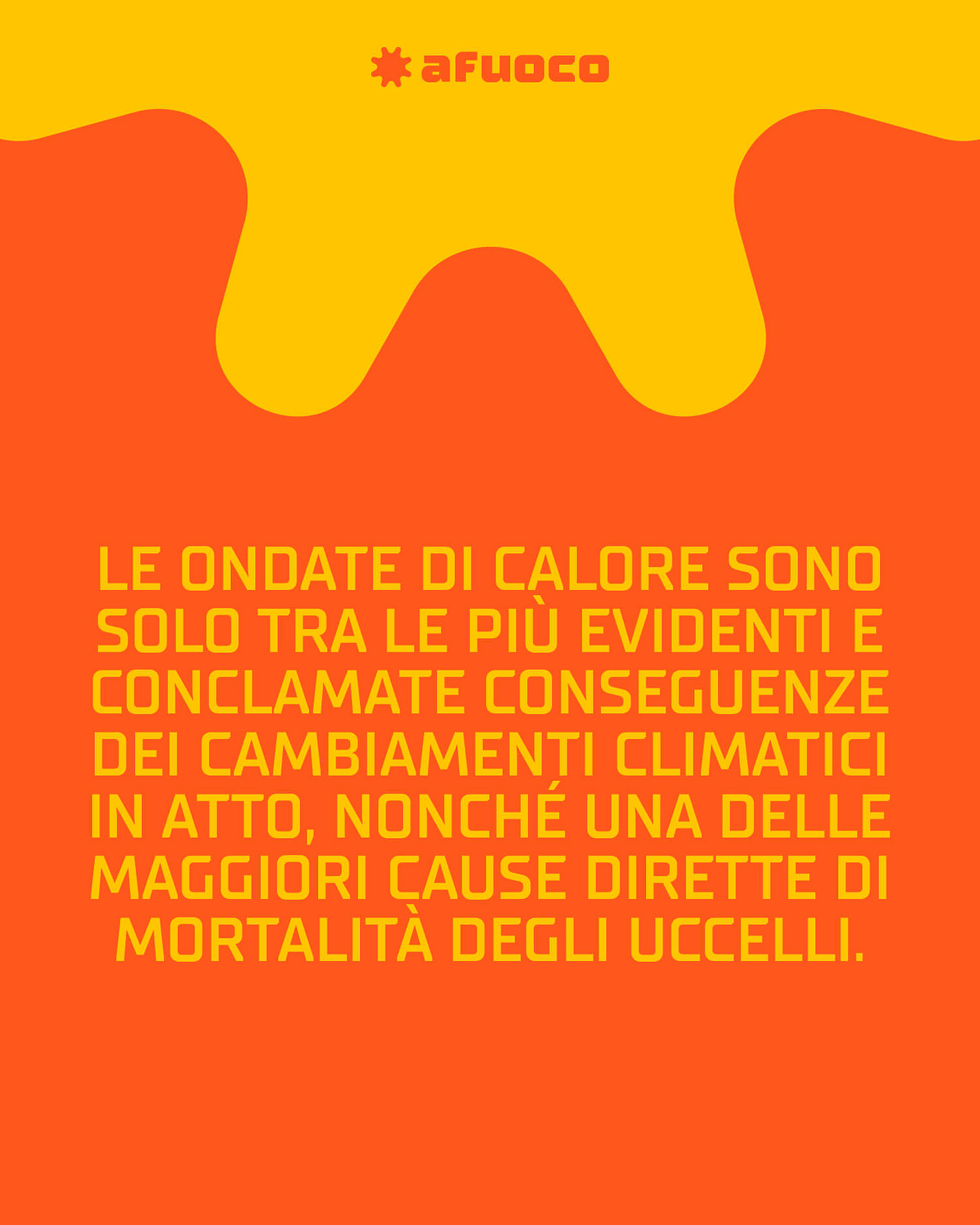È recente la notizia che una morìa di oltre 4 milioni di urie (Uria aalge), uccelli marini che nidificano in immense colonie lungo le coste settentrionali di oceano Atlantico e Pacifico, avvenne a causa di un’estrema ondata di calore che perdurò circa due anni (2014-2015) poco a largo dell’Alaska. L’avvenimento fu innescato da un incremento della temperatura del mare di circa di 3 gradi, definito blob di acqua calda, che ridusse drasticamente la quantità di plankton con effetti a cascata sull’intero ecosistema della regione. Oltre a effetti su pesci e mammiferi marini, portò al crollo demografico della popolazione di urie di circa il 50-80 per cento, per quello che è stato il più grande evento di mortalità di fauna selvatica documentato in età moderna.
Le ondate di calore sono solo tra le più evidenti e conclamate conseguenze dei cambiamenti climatici in atto, nonché una delle maggiori cause dirette di mortalità degli uccelli. Tale fenomeno non riguarda esclusivamente le specie marine e sembra essere diffuso in tutti gli ecosistemi a livello globale, non risparmiando nemmeno le specie adattate a climi aridi, perfino desertici.
Le difficoltà di fronteggiare eventi acuti di perturbazione ambientale risiedono solo in parte nel trovarsi in condizioni di drammatico depauperamento di risorse alimentari, come nel caso delle urie, o in contesti di distruzione massiccia degli ambienti in cui gli animali vivono, come in seguito ai recenti incendi in Australia e California. Più spesso riguardano la capacità di resistere a temperature estreme, che si spingono oltre la zona termoneutrale, l’intervallo di temperature entro cui ciascuna specie è in grado di sopravvivere. Quando il limite massimo di tolleranza viene superato, fenomeno sempre più di frequente e di crescente intensità, gli uccelli si trovano a forte rischio di disidratazione o ipertermia, che possono essere limitati solo spostandosi in luoghi più freschi o rimanendo attivi nelle ore meno calde della giornata. Tuttavia, questi accorgimenti sono ridotti o perfino preclusi a quelle frange della popolazione che hanno movimenti limitati, come gli individui in fase di cova o gli stadi giovanili confinati nei nidi da cui non possono fuggire. Non stupisce infatti che gli eventi di mortalità di massa più drammatici si verifichino spesso tra i giovani.
Se le risposte degli uccelli agli eventi climatici estremi sono difficili per la loro natura violenta e contingente, soprattutto se avvengono in fasi delicate del ciclo vitale, come riproduzione e migrazione, quelle nel lungo termine sono invece piuttosto comuni. L’altra faccia del cambiamento climatico sono infatti quelle lente alterazioni ambientali che avvengono nel tempo e nello spazio, andando, nel corso dei decenni, a modificare profondamente le caratteristiche degli ambienti a cui gli animali sono adattati, rendendoli meno ospitali. È ampia la letteratura riguardo alle risposte adattative degli uccelli alle nuove condizioni ecologiche e termiche a cui sono esposti, che risultano però spesso sufficienti solo a limitare gli effetti negativi sulle popolazioni piuttosto che ad azzerarli.
Tra le più documentate, si rilevano modifiche degli areali di distribuzione, con la ormai diffusa tendenza delle specie a spostarsi verso le regioni diventate climaticamente più idonee. E quindi ecco spiegati i movimenti sempre più frequenti e rapidi verso le latitudini polari, ma non solo. Anche le cime delle montagne stanno diventando dei veri e propri rifugi termici per le specie adattate ai climi freddi. Tuttavia, tali movimenti portano con sé due conseguenze negative. La prima risiede nell’inevitabile riduzione dello spazio a disposizione, che diviene sempre più ristretto (si pensi alle cime delle montagne) con conseguente contrazione delle popolazioni. La seconda riguarda il rimescolamento delle comunità ecologiche, con le sempre più frequenti invasioni in luoghi dove prima non erano presenti di specie adattate a climi più caldi. Queste potrebbero poi entrare in competizione diretta con le specie locali, riducendo la disponibilità di cibo e rifugi, nonché esercitare su di esse pressioni predatorie. È il caso dell’espansione altitudinale dell’allocco (Strix aluco) sulle Alpi, con possibili impatti sui rapaci notturni che vivono nelle foreste di conifere.
Un altro aspetto riguarda l’arrivo sempre più precoce degli “eventi primaverili” (fioriture, sviluppo degli stadi larvali degli insetti), che modificano fortemente la stagionalità. In risposta a tali cambiamenti stagionali, numerose popolazioni nidificanti a latitudini temperate e boreali tendono ad anticipare la tempistica (fenologia) della riproduzione negli anni più recenti rispetto al passato. Questo viene interpretato come un adattamento che consente di riprodursi in concomitanza del picco delle risorse nel momento di massima necessità, coincidente con quello dello sviluppo dei pulcini. Tuttavia, è altrettanto noto che tale anticipo risulta spesso insufficiente per stare al passo con l’arrivo sempre più precoce degli eventi primaverili, generando un vero e proprio sfasamento fenologico tra specie ecologicamente legate (ad esempio tra gli insettivori e le loro prede), con effetti demografici negativi per quelle che non sono in grado di seguire con sufficiente velocità il nuovo corso delle stagioni.
In questo contesto, è importante sottolineare che tale problematica riguarda soprattutto le specie migratrici, e in particolare i cosiddetti migratori a lungo raggio, quelli che trascorrono il proprio ciclo circannuale in luoghi distanti centinaia o migliaia di chilometri, spesso dislocati in continenti diversi. La tempistica della migrazione pone infatti un importante vincolo nel momento di arrivo nei luoghi di riproduzione, dovuto sia a fattori ambientali, tra cui la distanza migrata e le condizioni meteorologiche lungo la rotta, che a fattori intrinseci, come la muta del piumaggio annuale, necessaria per intraprendere il viaggio e che in molte specie avviene nei luoghi di svernamento. Sebbene tali specie stiano comunque anticipando le proprie migrazioni rispetto ai decenni precedenti, allo stesso tempo la loro riproduzione risulta ritardata se confrontata non solo con quelle stanziali ma soprattutto con il picco delle risorse su cui si basano. Un caso particolare riguarda però alcune popolazioni, come le rondini (Hirundo rustica) spagnole e siciliane, che hanno ridotto o perfino azzerato la distanza di migrazione, permanendo come residenti nei luoghi in cui nidificano, le cui temperature invernali sono divenute tollerabili. Una soluzione certamente pratica, sebbene le esponga al rischio di gelate invernali, le cui conseguenze demografiche andranno monitorate nei prossimi decenni.
Infine, un interessante fenomeno osservato negli ultimi anni è la progressiva riduzione della taglia corporea, accompagnata dall’incremento delle dimensioni delle appendici non piumate, come zampe e becchi, nei luoghi interessati da un intenso riscaldamento del clima. Questi veri e propri cambiamenti di forma, noti in letteratura come shape-shifting, sembrano riflettere un processo adattativo che favorisce la termoregolazione, in quanto animali di taglia piccola hanno un rapporto tra superficie e volume corporei maggiore rispetto a quelli più grossi (regola ecogeografica di Bergmann). Questa caratteristica, amplificata dalla presenza di appendici corporee estese (regola ecogeografica di Allen), consente infatti una più efficiente dispersione del calore, risultando quindi vantaggiosa in ambienti caldi. Tuttavia, l’entità degli effetti di questo cambiamento di forma sull’adattamento delle popolazioni e i meccanismi che la determinano non sono ancora del tutto chiari. Ad esempio, è possibile che la riduzione di taglia possa essere il sottoprodotto del degradamento ambientale, che riduce la disponibilità di cibo e quindi i processi di sviluppo, piuttosto che un vero e proprio adattamento, con ulteriori conseguenze negative sulla capacità di resilienza delle popolazioni.
Nel complesso, nonostante queste risposte compensative, secondo l’ultimo rapporto State of the World’s bird di BirdLife International, il 49 per cento delle specie di uccelli del mondo sono in calo demografico. Tra queste il 37 per cento risulta direttamente impattato dal cambiamento climatico e dagli eventi meteorologici estremi ad esso legato, una minaccia concreta che, sebbene non sia ad oggi la principale pressione antropica sugli uccelli, è destinata ad aumentare nel prossimo futuro. Si pensi, ad esempio, che il 97 per cento delle specie nordamericane si troverà a serio rischio entro il 2100 in uno scenario di incremento delle temperature di circa 3 gradi.
Un ennesimo campanello d’allarme che dovrebbe suggerirci di agire efficacemente e in tempi rapidi per evitare che gli effetti che si stanno già manifestando non diventino irreversibili. Ma potrebbe già essere troppo tardi. Lo sanno bene le urie dell’Alaska, che, dopo 10 anni dal blob di acqua calda, non hanno ancora mostrato nessun accenno di recupero demografico.
Andrea Romano è ecologo evoluzionista e comportamentale presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di Milano, dove svolge il ruolo di professore associato. Da 15 anni si occupa di ecologia e comportamento degli uccelli, con particolare riferimento alle risposte delle popolazioni al cambiamento climatico. In passato, ha svolto numerose attività di divulgazione scientifica, coordinando il sito Pikaia – Portale dell’evoluzione, e collaborando con diverse riviste, tra cui Le Scienze e Focus.
Memini climatici