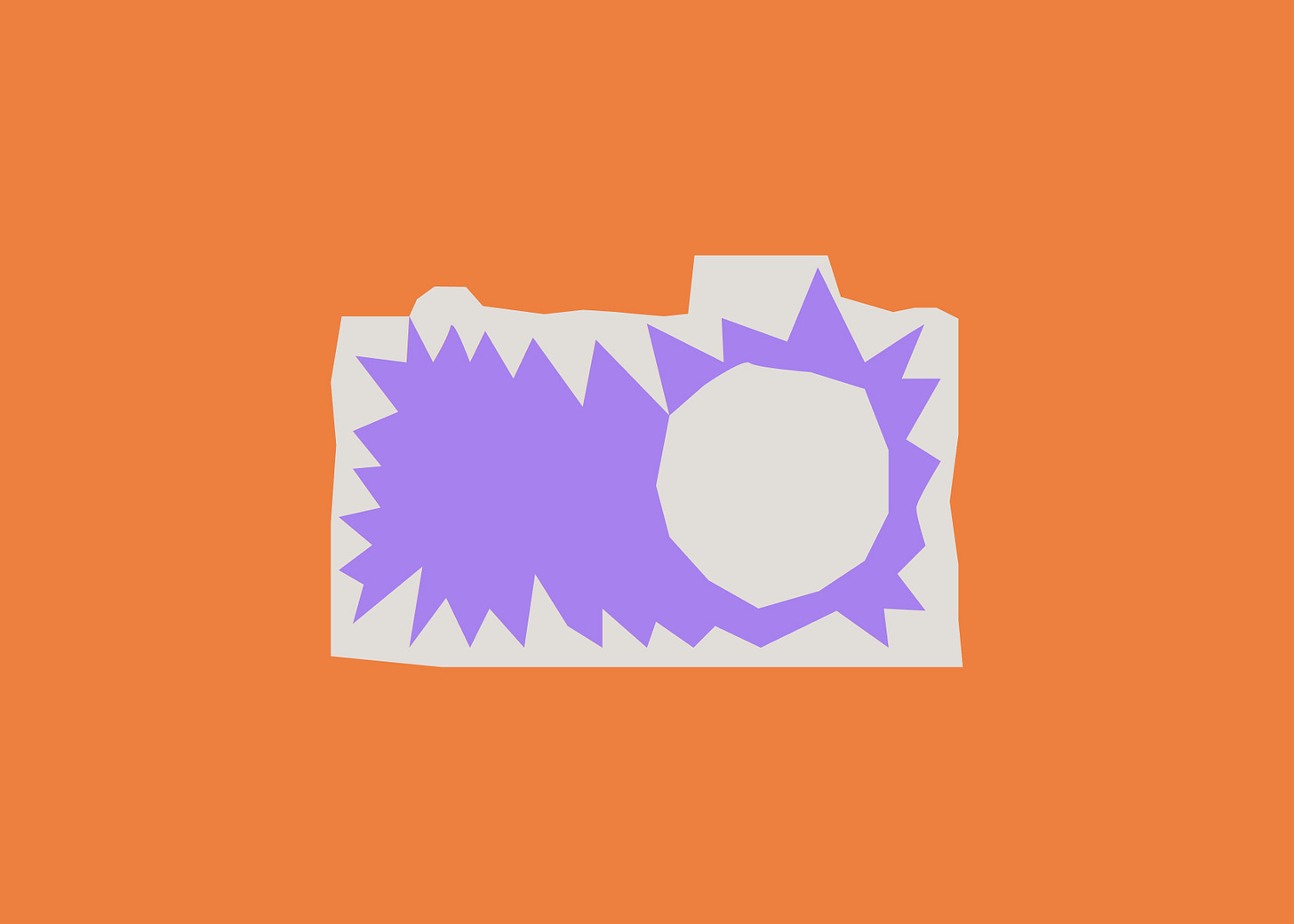Con il passare delle ore, il sole si fece meno rosso. Divampava sulla terra ricoperta di polvere. Gli uomini sedevano sulla soglia di casa; giocherellavano con pezzetti di legno o sassolini. Gli uomini sedevano immobili – pensando, interrogandosi.
(John Steinbeck, Furore, 1939)
Qualcuno potrebbe azzardarsi a dire che i contadini di Furore soffrissero in qualche modo di ecoansia. Le tempeste di polvere degli anni Trenta negli Stati Uniti avranno provocato del malessere psicologico, oltre che fisico e sociale? L’ambiente da sempre influenza la mente dell’uomo e ne condiziona le scelte di vita, la letteratura lo sa.
L’ecoansia dovuta ai cambiamenti climatici in atto è, però, un tema talmente recente che viene guardato a volte con sospetto, come se fosse in atto una congiura di vecchi e nuovi media per mandarci tutti dallo psichiatra. Il problema, semmai, è intendersi su cosa sia davvero l’ecoansia, evitando di scambiare un fenomeno pienamente esistente per un'etichetta diagnostica.
In altre parole, l’ecoansia non è una psicopatologia, non è presente nei manuali utilizzati dagli specialisti per individuare un problema clinico. Però, questo non vuol dire che non si possa soffrire per lo stato in cui si trova il nostro pianeta, e che tali sofferenze non meritino di essere prese sul serio.
«Quello che conta è il percepito delle persone, cioè che ci sia una grande cambiamento a livello climatico verso il peggioramento, con fenomeni estremi che turbano quel senso di ordine e continuità cui eravamo abituati», mi spiega Gianluca Castelnuovo, ordinario di Psicologia clinica all’Università Cattolica di Milano e direttore del laboratorio e servizio di psicologia clinica e psicoterapia dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano. Per la rivista Frontiers in psychology, si è occupato di una chiamata alle armi rivolta a ricercatori preparati a mettere in relazione la psicologia clinica e i cambiamenti climatici. Quando nel laboratorio dell’Auxologico indossa la giacca del clinico, invece, Castelnuovo riscontra direttamente il fenomeno, raccontandomi che anche loro stanno assistendo a un aumento di disturbi legati all’ambiente. Perché, sebbene l’ecoansia non sia una psicopatologia, i cambiamenti climatici possono alimentare disturbi clinici – come fobie o disturbi generalizzati d’ansia – per una ristretta minoranza di persone.
Per individuare la soglia tra malessere e problema clinico vi faccio un esempio banale: quest’estate, al mare, mi infastidiva oltremisura veder utilizzare le bottiglie d’acqua in plastica usa e getta. «Un conto» spiega Castelnuovo, «è se la sua ossessione avesse portato a effetti clinicamente significativi nella quotidianità. Per parlare di psicopatologia devo avere un impatto forte in una delle aree del funzionamento della vita: professionale o scolastico, familiare, personale». La maggioranza degli ecoansiosi fortunatamente resta al di sotto della soglia clinica, e io con loro.
Ma, allora, cosa ci porta a soffrire comunque quando riflettiamo sulle sorti del pianeta? Secondo una definizione, riportata anche dall’Osservatorio europeo del clima e della salute, l’ecoansia è la paura cronica di un cataclisma ambientale che deriva dall’osservazione dell’impatto dei cambiamenti climatici e la preoccupazione per il proprio futuro e quello delle generazioni a venire.
Tutto sommato, quindi, una risposta abbastanza razionale di fronte a un problema che non si può risolvere da un giorno all’altro. «C’è dietro un grande tema» secondo Castelnuovo, «ed è quello della perdita del controllo, comune a tante situazioni cliniche o subcliniche. L’uomo moderno, soprattutto occidentale, ha sempre avuto il desiderio di mantenere il controllo nei confronti di ciò che accade nel mondo». Figuriamoci quando l’ambiente in cui siamo immersi non offre più quel senso di sicurezza e prevedibilità cui eravamo abituati, altro che controllo – con un cordiale saluto a complottisti grandi e piccini.
Ciononostante, per noi ecoansiosi subclinici esistono alcune strategie utili. La prima è cercare di riequilibrare l’idea di un ambiente minaccioso e quasi intenzionalmente malevolo e vendicativo, attingendo non solo alle cronache dei disastri ma anche alle notizie di segno positivo (come ha ricordato Ferdinando Cotugno nella terza puntata di A Fuoco: non è ancora troppo tardi per intervenire sui cambiamenti climatici). La seconda è un po’ la stessa idea perseguita con altri mezzi: ritagliarsi degli spazi per apprezzare quello che la natura ha da offrire. E poi, il consiglio di sopravvivenza più vecchio del mondo: adattarsi. In un articolo del New Yorker, una psicoterapeuta esperta di climate therapy ha raccontato gli sforzi per far trovare ai propri clienti uno spazio mentale di preoccupazione sostenibile, cercando di metterli più a proprio agio anche nell’incertezza.
C’è un ultimo aspetto da non trascurare nemmeno quando si tratta di questioni ambientali: la nostra salute mentale ha una dimensione collettiva e politica. In questo caso, il senso di impotenza può essere mitigato dal senso di comunità, prendendo parte ad alcune iniziative sul tema. La britannica Climate Psychology Alliance offre spunto su alcune forme, come il climate cafè, una formula d’incontro mutuata al death cafè – evento pubblico no-profit in cui i partecipanti discutono sul tema della morte consumando cibo e bevande – ma ce ne possono essere altre. A me è venuta in mente la guerrilla gardening che ho visto praticare a Napoli già oltre dieci anni fa dal gruppo dei Friarielli Ribelli. Ma basta (e si fa per dire) anche solo non dimenticare di far valere il nostro diritto alla salute, fisica e mentale, tenendo conto se possibile anche di quel che accade in luoghi meno privilegiati.
Ripensando agli uomini di Furore, seduti sulla soglia di casa, mi sono domandata se in fin dei conti l’ecoansia non fosse una nuova veste per la solita vecchia paura dell’Apocalisse. «Sì, ma poi noi ci troviamo queste persone in ambulatorio, anche se è la solita vecchia cosa», risponde Castelnuovo prima di andare e rimettersi la giacca del clinico.
Questo articolo è stato scritto ascoltando Darklands dei The Jesus and Mary Chain.
Jessica Mariana Masucci è una giornalista. Scrive di attualità per varie testate (Lucy sulla cultura, L’Espresso, Marie Claire, Il Foglio e altri) e ha lavorato per l’ANSA. Ha pubblicato nel 2023 Il fronte psichico. Inchiesta sulla salute mentale degli italiani, ed. nottetempo. Ha una newsletter su Substack: Stati di salute.
Di persona
Raccontare la crisi climatica e non parlare del meteo: Giovanni Zagni (direttore di Pagella Politica e Facta.news) e Alberto Puliafito (direttore di Slow News) si confrontano su come fare giornalismo ambientale nel 2023. È l’occasione per parlare del nuovo progetto che le due testate hanno realizzato insieme: A Fuoco. Vedremo metodi e strumenti per affrontare una delle più importanti sfide del giornalismo del presente e del futuro.
🎟️ Prenota un posto in presenza qui
💻 Prenota qui per lo streaming e l’on demand.
Strumenti che puoi usare anche tu: ecodidattica
Questa settimana ti segnaliamo qualcosa più di uno strumento. È un metodo, un approccio al mondo – non solo quello che riguarda la crisi climatica – che può rappresentare possibili soluzioni a molti problemi. Alessandro Marescotti, insegnante impegnato «nella battaglia di informazione e denuncia del disastro sanitario e ambientale di Taranto e della sua provincia», ha realizzato una guida all’educazione ambientale utilizzando le nuove macchine chiamate intelligenze artificiali generative. La guida, che si chiama Ecodidattica con ChatGPT, è contenuta in questo documento a disposizione di chiunque voglia leggerlo, scoprire come è stato realizzato, utilizzarlo o replicarne la metodologia per progetti comparabili.
A Fuoco è un progetto collaborativo. Vuoi partecipare?
Rispondi al nostro sondaggio sul giornalismo climatico: aiutaci a capire cosa manca e cosa si può migliorare nell’informazione sulla crisi climatica nei media italiani.