Nel tentativo di capire cosa stia incagliando la transizione ecologica, a volte ci comportiamo come quell'ubriaco che non riesce a trovare le chiavi di casa. È una piccola parabola su come funziona la mente umana, codificata, tra gli altri, anche da Noam Chomsky. «L'ubriaco cerca le chiavi di casa sotto il lampione, dall'altro lato della strada rispetto a dove gli erano cadute. Quando gli chiedono perché le cerchi proprio lì, e non dove le aveva perse, l'ubriaco risponde: perché qui c'è la luce e si vede meglio». Questa metafora è utile per spiegare il rapporto che abbiamo sviluppato con la disinformazione climatica, che è un grande problema, ma sta anche diventando la luce sotto la quale cerchiamo tutto, una risposta passepartout per spiegare quello che non sta funzionando socialmente e politicamente con la transizione, i motivi per cui viene così spesso rifiutata, perché fa così paura, anche in un'Unione Europea dove tre quarti delle persone considerano il cambiamento climatico un problema «molto serio» (dati Eurobarometro).
Stiamo vivendo nell'illusione che ogni scetticismo climatico sia un effetto della disinformazione organizzata e che, una volta risolto quel problema, la transizione potrà finalmente correre veloce e spedita verso l'orizzonte net zero e gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Non è così. Lo ha spiegato bene la sociologa Holly Buck in un articolo uscito qualche mese fa su Jacobin: «L'ossessione per la disinformazione climatica è uno spreco di energie e un vicolo cieco strategico, fa parte della tendenza liberal a fare della disinformazione lo spauracchio da incolpare per tutti i nostri problemi politici».
Intendiamoci, il negazionismo organizzato continua a fare danni, e non voglio suggerire che vada sottovalutato, anche perché nel frattempo si sta evolvendo e adattando. Alla COP29, Climate Action Against Disinformation ha presentato un nuovo rapporto, intitolato Extreme Weather, Extreme Content, che mostra come le aziende oil and gas siano sempre più alleate con i giganti della tecnologia per diffondere informazioni false sul clima. I social sono assediati da un piccolo gruppo di super diffusori di disinformazione climatica. Meta nel 2023 ha incassato 17,6 milioni di dollari dai principali otto inserzionisti fossili per l'amplificazione della propaganda negazionista, che ha raggiunto così 700 milioni di utenti in dodici mesi, facendo danni sociali e culturali incalcolabili.
Il punto però è che non scioglieremo questi nodi limitandoci a presidiare la disinformazione, né si può vincere questa battaglia politica trasformandola in una culture war iper-polarizzata, nella quale bisogna riconoscersi per schieramenti e squadre su ogni tema, dalla pulizia dei fiumi all'attribuzione climatica degli eventi estremi passando per lo smaltimento di batterie e pannelli. Nel 2020 Joe Biden vinse le primarie democratiche e poi le presidenziali mettendo la lotta ai cambiamenti climatici al centro del suo programma e usandola per compattare il suo fianco sinistro: aveva visto che lì, sul clima, c'era un enorme capitale politico da conquistare. Da allora è cambiato tutto. Quattro anni dopo, Kamala Harris (che pure partiva da posizioni ecologicamente più radicali di Biden) ha fatto la scelta opposta: tenersi alla larga dal discorso sulla transizione, che in un solo ciclo elettorale era diventata politicamente tossica, quindi meglio parlarne il meno possibile. I risultati dimostrano come sia stata una delle tante pessime idee della sua campagna, ma la scelta fatta in modo così netto mostra come sia cambiata la percezione del tema.
Anche in Italia la giunta progressista in Sardegna di Todde si è messa contro gli ambientalisti, prima con una moratoria di diciotto mesi per i nuovi progetti di rinnovabili, poi con un disciplina sulle aree idonee rigidissima. Sono scelte fatte sulla scia di un'ostilità contro eolico e fotovoltaico sull'isola, che negli ultimi anni è diventata un laboratorio delle difficoltà di parlare di transizione. E non possiamo dare tutta la colpa alla disinformazione, che è un ingrediente del mix, ma si farebbero un torto ai sardi e un errore politico a rifugiarsi in questo pensiero: sarebbe come cercare le chiavi sotto il lampione, anche se sappiamo che non sono lì. I sardi non sono destinatari passivi di un messaggio distorto. La Sardegna è la prova di cosa succede quando un cambiamento così grande viene calato dall'alto, senza spiegazioni e meccanismi di partecipazione, come un dato di fatto a cui si può solo obbedire o ribellarsi, senza vie di mezzo.
A gennaio di quest'anno, uno studio del Center for Countering Digital Hate aveva codificato il concetto di «new climate denial», il negazionismo di nuova generazione. Fino al 2018 il negazionismo vecchia scuola (quello che dice: «il clima non sta cambiando», o «il clima è sempre cambiato», o «i cambiamenti climatici non dipendono dalle attività umane») rappresentava i due terzi dei contenuti digitali identificabili come anti-clima. Da allora la strategia è cambiata: il nuovo negazionismo ruota intorno a discorsi come «le soluzioni non funzionano» oppure «gli esperti sono inaffidabili». Secondo lo studio questi contenuti hanno sostituito, per quantità, quelli della vecchia scuola.
Il discorso sul «nuovo negazionismo» però ci porta su un terreno scivoloso. È vero che esistono i «mercanti di dubbi», come suggeriva il titolo di uno dei libri più importanti sul tema, quello di Naomi Oreskes e Erik M. Conway, ma non tutti i dubbi sono frutto di una manipolazione. Anzi, dobbiamo iniziare a prendere sul serio i dubbi delle persone e delle comunità sulla transizione, nell'interesse della transizione stessa. Perché oggi il rischio per il discorso sul clima è creare una rigida ortodossia del climaticamente corretto, in cui qualunque domanda sulle rinnovabili, le pompe di calore o le auto elettriche viene tacciata come negazionismo, con l'effetto di consegnare le persone in massa al negazionismo, quando negazioniste non sono.
La scienza sulla crisi climatica è solida: lo è sui rischi che corre la civiltà umana e lo è sull'urgenza di agire. La transizione invece è ancora da scrivere e implica scelte che influiranno profondamente nella nostra vita nei prossimi decenni. Le soluzioni ci sono e tendenzialmente funzionano, ma hanno sia benefici che costi, che devono essere parte del dibattito pubblico. Uno degli effetti cronici della disinformazione sul nostro dibattito pubblico è aver cristallizzato l'idea di uno status quo energetico impossibile da modificare, basato sulle fonti fossili, che ci dovrà accompagnare ancora per decenni, ben oltre la finestra di tempo per stabilizzare il clima. La scienza ci dice che non è vero, ma non possiamo pretendere di sostituire un'ortodossia con un'altra ortodossia, perché la transizione non è un monolite né esiste un'unica ricetta. Il dibattito democratico su come spostarci, viaggiare, illuminare, riscaldare, compensare, riparare, adattare deve essere allargato, non ristretto. E, per essere allargato, bisogna accogliere le domande, farsene carico, prendersene cura. Anche se (e non sempre è così) sono frutto di una paura irrazionale.
Impostare il discorso sulla transizione sui parametri di un climaticamente corretto non soggetto al dibattito vuol dire fornire ragioni a chi descrive la decarbonizzazione come il piano di un'élite contro il popolo. Sappiamo che non è così: gli effetti dei cambiamenti climatici colpiranno in maniera sproporzionata le persone più vulnerabili e molte delle tecnologie della transizione (non tutte, ma molte) hanno un potenziale democratico e popolare che oleodotti e rigassificatori non avranno mai. Ma dobbiamo essere disposti a spiegarlo, accettare la fatica del confronto democratico, partire dal presupposto che nessuna domanda sia sbagliata e che nessuno, nessun partito, attivista, movimento, organizzazione di settore, avrà da solo tutte le risposte.
Durante la COP29, un dirigente del ministro dell'ambiente, Alessandro Guerri, ha incontrato una rappresentanza dei movimenti ambientalisti italiani. A loro, si è lasciato sfuggire frasi che hanno scatenato un putiferio e portato alla smentita del ministro, ma che sono indicative della tendenza a sottrarre il dibattito su clima ed energia dalla fatica della democrazia e delle domande che comporta. «Lo sapete chi sono i nemici della transizione? Gli ambientalisti», ha detto Guerri agli ambientalisti, e poi: «La partecipazione della popolazione è la garanzia del fallimento dei progetti». Non è una novità: è così che sono sempre state costruite le politiche energetiche in Italia, ma la transizione e il passaggio alle rinnovabili ci danno l'opportunità di fare le cose in modo diverso, più aperto, partecipato e democratico. Ma per riuscirci bisogna accettare il confronto, anche quando è scomodo.
Ferdinando Cotugno è un giornalista, si occupa di clima e politica, scrive per il quotidiano Domani, per il quale cura anche la newsletter AREALE. Nel 2020 ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori), nel 2022 è uscito Primavera ambientale (Il Margine). Conduce (con Luigi Torreggiani e Giorgio Vacchiano) il podcast Ecotoni.
Il podcast di A Fuoco
Il 2024 sarà ricordato come il primo anno con una temperatura media globale oltre 1,5°C rispetto all’era pre-industriale. Eppure, c’è chi nega la crisi climatica o minimizza il ruolo umano.
Questa è la quarta puntata del nuovo podcast di A Fuoco, scritto e condotto da Anna Toniolo, prodotto da Jessica Mariana Masucci. Nell’episodio di oggi chiacchiereremo con Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza.
Memini climatici
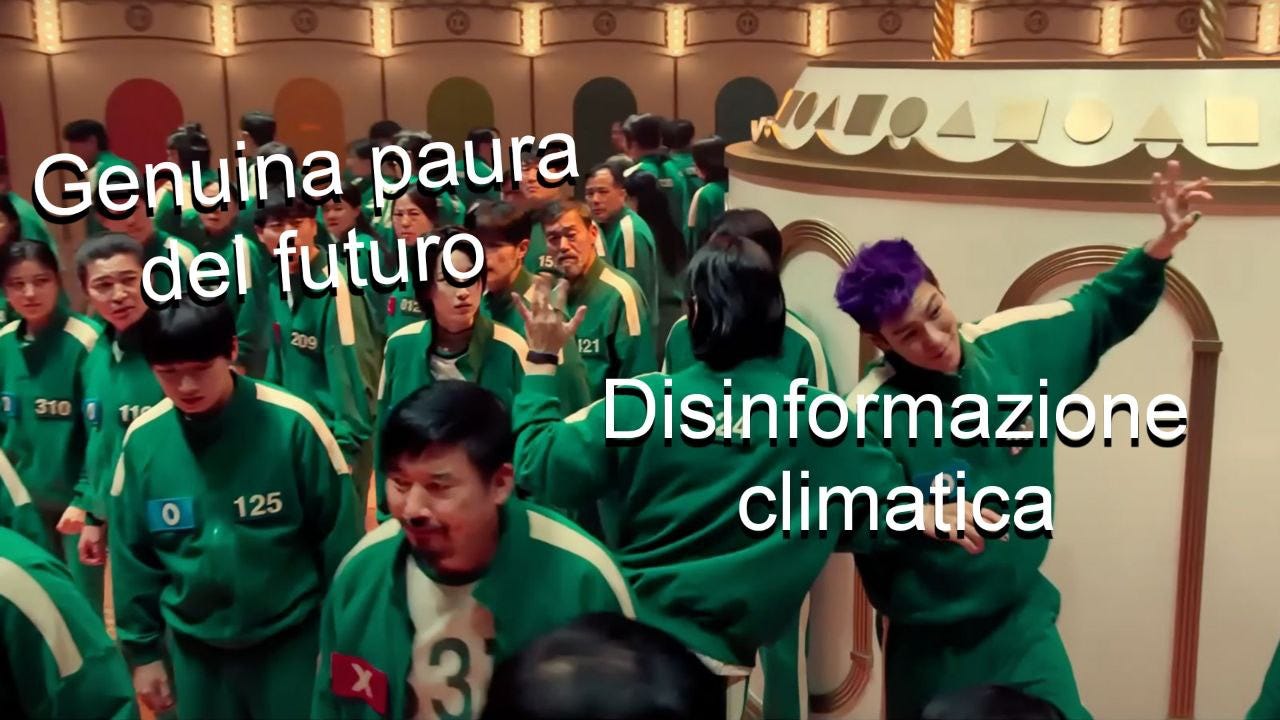









Ferdinando si concentri meglio su quello che sta accadendo in Sardegna, nell'articolo la questione è trattata in modo superficiale.